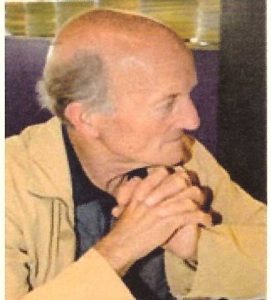L’eremo del deserto

Mestieri
missionarioLivello di scolarizzazione
laureaPaesi di emigrazione
AlgeriaData di partenza
1964Periodo storico
Periodo post seconda guerra mondiale (1946-1976)


Temi
religioneTemi
religioneCosimo Piccolo arriva nell’eremo di Benì Abbes, nel bel mezzo del deserto in Algeria, e prende contatto con i confratelli che già popolano l’eremo nel quale trascorrerà alcuni mesi di vita comunitaria.
Mi separavano da Béni-Abbès poco più di duecento chilometri. Una macchina mi aveva portato ad Igli, una piccola oasi di una cinquantina di palme e una decina di casette bianche tutte uguali. Cominciava il grande deserto (l’Erg Occidentale). L’ultima macchina mi aveva lasciato all’incrocio di diverse piste, ad una decina di chilometri dall’attesa, quanto sospirata meta. Indimenticabile l’immagine di Béni-Abbès lambita dagli ultimi raggi di sole. L’oasi m’apparve vestita di tutta la sua bellezza. Le palme che da lontano mi avevano guidato, ancora scintillavano con la loro chioma verde smeraldo. Mi fermai davanti alla prima casa che incontrai, per chiedere dov’era la Fraternità. Sull’uscio apparve un ragazzino che poteva avere nove, dieci anni, che mi guardò con quell’aria come se sapesse già la mia domanda. “Cherchet vous la Fraternità?”, mi chiese. “Oui!”, gli risposi. E mentre mi diceva: “Atendai vous”, scomparve per un attimo nella penombra della casa. Tornò per accompagnarmi. Khais, conosceva bene la Fraternità. Ci veniva spesso, specialmente quando arrivavano i Fratelli. Sapeva che gli scappava sempre qualche “bon-bon”. L’eremo si trovava dall’altra parte dell’oasi, a circa un chilometro dall’abitato. Spiccava la croce in ferro battuto posta su un rialzo dí mattoni al centro del cortile. Mi vennero incontro Antonio, Cesar e Raoul. Gli unici ad essere arrivati prima di me. Quella casa lì, fuori dal villaggio, ma allo stesso tempo a due passi dalla gente, era come un ponte lanciato tra due inondi, due culture, due fedi ugualmente grandi. Era stata per questo voluta dal “Marabutto” (fratello), come lo chiamavano gli amici arabi. Lui, l’innamorato di Gesù di Nazareth, suo “Modello Unico”, era diventato per i musulmani, l’amico, l’uomo di preghiera, l’esempio vivente dell’uomo di Dio, per cui il suo unico, più grande desiderio, era quello di farsi “Arabo con gli arabi, nomade con i nomadi, tuareg con i tuareg, fino a morire per loro”, come scriveva nel diario il diciassette maggio millenovecentoquattordici, due anni prima di morire, ucciso per un fatale errore, avverandosi così la sua profezia: “se un chicco di grano non muore, non porta frutti”. E di frutti lui ne portò, anche se in vita non ebbe nessun discepolo disponibile a seguirlo sull’esempio di Gesù a Nazareth.
L’eremo era così come l’aveva costruito Charles de Foucauld, con l’aiuto di alcuni suoi amici di Béni-Abbès. Come in tutte le Fraternità la cappella è l’angolo più vivo, più curato e quella era al superlativo. Il pavimento era di sabbia, la stessa delle dune, così che in ginocchio davanti al tabernacolo era come stare all’aperto, nell’immenso mare di fuori. Sul piccolo altare sovrastava la grande immagine di Gesù risorto e sullo sfondo la croce, così da realizzare i due momenti in una sola immagine, dalle sue stese mani dipinta di azzurro, il colore predominante. Lungo le pareti laterali della lunga stanza a tre navate, c’erano le stazioni della via crucis, anche queste disegnate dalla stessa mano. In quei quaranta giorni, quella cappella sarà tutto il mio mondo. L’unica attività per me fu la costruzione di dodici paia di sandali, uno per ogni fratello, compreso Pierre, se si esclude qualche giornata di lavoro con Ermete e con Raoul, nell’orto, vicino al oued, dove grazie all’acqua riuscivamo a raccogliere diverse specie di ortaggi. Ermete arrivò con Carlo verso la fine del Noviziato. Di lui ricorderò le mani di muratore, pesanti e grandi, mentre l’aiutavo a costruire mattoni impastati con sabbia e paglia. Invece, l’arte di costruire i sandali l’avevo appreso da fratel Carlo a Spello.
Nel piccolo “atelier” trovai un foglio di cuoio e v’erano alcuni copertoni d’auto abbandonati. In una settimana tutti i fratelli avevano ai piedi sandali garantiti, per fare l’intero giro del mondo. Quanti chilometri ho percorso con quei sandali, non solo sulle dune, ma per le strade del mondo in quegli anni! E sulle strade spesso sognavo di volare. Sì, volare fu l’altra grande sensazione che provavo di notte, durante quei giorni di deserto. La vita a Béni Abbès non finiva mai di stupirmi. Sognavo sempre. Mi sentivo così leggero da avere ed essere portato dal vento. Volavo letteralmente. Volavo… Volavo… Volavo Nel sonno decollavo ora dai bordi dell’eremo, ora dalle cime delle palme, e facevo il giro trasvolando tutta l’oasi. Erano così intense e vere quelle emozioni, che la mattina appena alzato ero convinto d’aver volato, d’esser stato sopra al “Museo dei rettili (dove ero stato alcune volte ad ammirare le numerose specie degli animali del deserto), alla casa dell’amico Gaby, col suo cortile e la piccola serra dei fiori, che era il suo vanto, e che ogni volta che passavo, quando andavo al villaggio, voleva che mi fermassi a guardarla, oltre che a prendere il suo buon thè. Volare m’era diventato così facile e familiare, da conoscerne tutti i segreti. Bastava che agitassi le braccia, come fossero ali, che mi staccavo da terra e prendevo il volo. I fratelli mi chiedevano di insegnarli quel gioco, ma non ci riuscivano.
Béni-Abbès era un villaggio povero Prima dell’indipendenza (1964) contava un migliaio di abitanti. Quando arrivai s’era ridotto a meno della metà. Erano rimasti anziani e bambini. I primi li si vedeva raramente per le strade con i loro “bournous” (mantello arabo, di lana di pecora), e qualcuno già con la “gandura” bianca, (una specie di tunica leggera, visto l’avvicinarsi della stagione calda), soli, che lentamente scivolavano lungo i margini delle case, in cerca di ombra. Quasi tutti afflitti da tracoma. I loro occhi, infatti, serrati ai bagliori intensi di quella luce inesorabile, sembravano fustigati dalle profonde rughe, quasi fossero maschere di dolore. I bambini guizzavano sul morbido tappeto di sabbia, sempre in cerca di qualcosa per sé, o per la famiglia. Ricordo il primo giorno che andai nel villaggio. Seduto davanti ad una casa vidi un bambino sui tre, quattro anni, il cui viso era letteralmente attaccato dalle mosche. Specialmente gli occhi e le labbra non si distinguevano più. Lui immobile, senza un gesto per allontanare quegli insetti arrabbiati per qualcosa da succhiare. Doveva essere abituato a quel supplizio. Ma quanta sofferenza! Chissà da quando non veniva lavato quel viso! Cominciavo a scoprire l’immenso valore di quel bene elementare e quotidiano che noi in Occidente sprechiamo: l’acqua. Nel deserto l’acqua non c’è, o quanto meno è nascosta. Il “oued” (fiume) spesso si prosciuga, o prende vie sotterranee. Bisogna usare l’acqua con parsimonia. Allora si scopre il valere di un bene, quando ci viene a mancare. E mi colpiva il profondo senso della loro condivisione. Per esempio era quasi impossibile vedere un tuareg, o un berbero, bere o mangiare da solo, senza condividerlo con i presenti. La loro fedeltà alla preghiera ripetuta e scandita in ben cinque momenti della giornata, dal “Muezzin”, il quale con voce stentorea racconta (e ricorda) la grandezza e la misericordia di “Allah akbar” (Dio è il più grande). L’Islam mi appariva come un mondo di uomini che aspettano, come se vivessero per un’attesa. Ovunque sostavano uomini erano in atteggiamento di preghiera. La stessa tenda del beduino sta ad indicare la precarietà, il cammino della vita, l’attesa del nuovo giorno, la fede nell’unico Dio. La Fraternità era un luogo d’incontro e di amicizia con il mondo musulmano. Un incontro che non si basava su descrizioni dottrinali, bensì sul rispetto reciproco, sulla solidarietà, sui valori condivisi, proprio come aveva voluto Charles de Foucauld , “il Marabutto” dei berberi e dei tuareg. Era così che le parole di Gesù: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni…” diventavano realtà, alla stessa maniera delle altre: “Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”. Mi affascinava anche la loro serenità e la padronanza del tempo, la loro calma al punto da apparire indifferenza, apatia. Cominciavo ad interiorizzare la domanda “Chi è l’altro bisognoso?”. Tutto il mondo circostante era una risposta chiara ed inequivocabile. Ma l’altro bisognoso per me non finiva ai fratelli musulmani. Giungevano notizie, tramite diari di fraternità, di tragedie d’ogni genere che si consumavano in un po’ tutto il mondo, dall’Africa, con il conflitto bellico nel Biafra, all’Asia, con la guerra in Vietnam e in Europa con le devastanti conseguenze per la debole democrazia della “Primavera di Praga” di Dubcek, dovute all’invasione dei Russi. Ma l’importanza dell’altro bisognoso che soffre e muore per le vie del mondo, per me sperduto in quel deserto passava dall’amicizia e solidarietà con i volti dei bambini, delle donne (anche se questi erano velati), degli uomini di Béni Abbès. Sentivo di portarmi dentro tante persone diverse e che io stesso ero un po’ tutti gli altri, con la loro rassegnazione e povertà, le loro sconfitte e resurrezioni.
Il viaggio

Mestieri
missionarioLivello di scolarizzazione
laureaPaesi di emigrazione
AlgeriaData di partenza
1964Periodo storico
Periodo post seconda guerra mondiale (1946-1976)Gli altri racconti di Cosimo Piccolo
Vita di Fraternità
La vita dei Piccoli Fratelli di Gesù così come descritta attraverso le "lettere dalle Fraternità" di...
In Francia in autostop
Cominciavo ad affezionarmi a quella Comunità generosa e legata alle sue radici, al suo passato, quando...
Vita in comunità
I giorni erano scanditi dalla sveglia alle cinque. Alle cinque e un quarto bisognava essere in...
Nel deserto
Viaggiare mi ha sempre messo addosso un senso di nostalgia, misto ad un senso di tristezza....